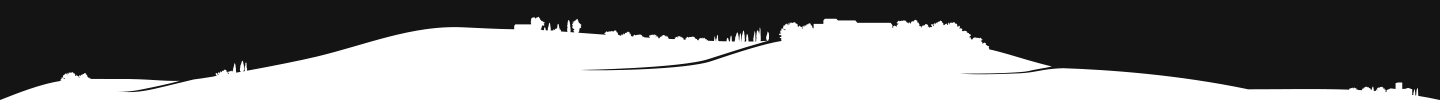Un rito antico, un’operazione agricola complessa, che richiede una valutazione attenta del grado di maturazione dell’uva destinata alla vinificazione.
Da millenni, la vendemmia è un momento cruciale per l’esistenza umana. Da essa dipende la produzione del vino e, per secoli, pure l’inizio di un nuovo ciclo stagionale. Prima dell’avvento dei calendari fissi, erano i giorni della vendemmia a segnare la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. E per questo, tale attività veniva regolamentata in senso rituale e poi celebrata con feste e fiere rispettate e onorate da tutta la società.
Ancora oggi la vendemmia è una fase delicata e fondamentale per la viticoltura. Si tratta del momento in cui è possibile determinare la qualità dell’annata e il valore commerciale del vino.
Senza vendemmia, non ci sarebbe vino. E senza vino, crollerebbe un intero comparto economico che coinvolge agricoltori, distributori, ristoratori, rivenditori, enologi… E l’essere umano dovrebbe rinunciare a una delle bevande più suggestive e raffinate in circolazione.
Cos’è la vendemmia e perché è così importante
Tecnica, tradizione e intuizione suggeriscono al viticoltore qual è il momento giusto per raccogliere l’uva da trasformare in vino. E quel momento dovrebbe corrispondere al culmine di un ciclo biologico e culturale, a una particolare congiuntura dove la natura cede il passo all’ingegno umano.
La vendemmia è anche un punto di partenza per arrivare al prodotto finale: alla bottiglia che sarà stappata, per farsi espressione di un territorio, di un particolare gusto, di un’annata e di una storia.
Da un punto di vista tecnico, la vendemmia è importante per capire se l’uva ha raggiunto il giusto grado zuccherino, se il clima ha permesso una maturazione equilibrata o confacente agli standard del produttore. In base a tali analisi, il viticoltore deciderà se intervenire con opportune tecniche di selezione, se aprirsi al blend, procedere con l’appassimento o pensare a una vinificazione speciale.
Origini e valore culturale della vendemmia
Per gli antichi greci, il vino era un mistero, un dono divino: era il lascito di Dioniso, dio dell’estasi e dell’ebbrezza, del superamento dell’ordinario. E le vendemmie erano appunto celebrazioni dedicate alla divinità errante, simbolo della frenetica corrente di vita che tutto pervade… In campagna e nelle città, tutti celebravano Dioniso, con riti, banchetti e feste. Alcuni cortei, frequentati soprattutto da donne, si abbandonavano al ritmo vorticoso del ditirambo e alle danze più ossessive.
Da un lato, dunque, si celebrava il dio civilizzatore che aveva insegnato all’uomo a coltivare la vite e si festeggiava nei giorni di vendemmia il valore culturale e sociale di un’attività importante per tutti, connessa all’abbondanza, alla salute e alla sapienza. Dall’altro, ci si lasciava andare a espressioni rituali più brutali e caotiche, come i riti cruenti descritti da Euripide ne Le Baccanti.
I Romani trasformarono Dioniso in Bacco e cercarono di reprimere gli eccessi festosi della vendemmia, trasformando questo momento dell’anno in una celebrazione del lavoro…
In realtà, i misteri legati al prodigio della trasformazione dell’uva in bevanda inebriante non sono mai scomparsi del tutto. Nel Medioevo, quando la vendemmia divenne evento comunitario, scandito da canti e preghiere, e quindi controllato dalla Chiesa, i contadini continuavano, sempre di nascosto, a inneggiare a spiriti naturali e a lasciarsi andare a pratiche superstiziose. Feste tese a rinsaldare il legame con la terra, a esprimere la gioia primordiale e ad allontanare da sé tutte le cose sgradite, attraverso grandi bevute di vino nuovo e balli estatici.
Ancora oggi, in molte zone d’Italia, la vendemmia continua a essere intesa come una festa: un momento simbolico e culturale che unisce le persone e le generazioni. Il contadino che per mesi ha lavorato la terra, curando le viti, aspettando la pioggia e temendo grandine e gelate, come potrebbe non festeggiare il momento della raccolta? E un tempo era tutto il paese a gioire dell’evento: servi, coloni, monaci, artigiani, signori…
La vendemmia tra festa e lavoro
Prima di ogni festa, però, c’è la fatica. I contadini si svegliano all’alba, si sporcano le mani, si spezzano la schiena. La vendemmia, nell’epoca digitale, può essere ancora fatta a mano, proprio come si faceva più di duemila anni fa. Oppure ci si può attrezzare con macchine vendemmiatrici, che scuotono i filari e raccolgono tutto. Ma anche in quel caso c’è da sudare, da lavorare con attenzione.
E per chi lavora, spesso la raccolta è già di per sé un evento da celebrare, un momento di grande importanza, in cui si sta insieme, ci si confronta e ci si prepara alla fine di un ciclo. Quasi una forma di resistenza culturale. Contro l’omologazione e la meccanizzazione totale dell’esistenza.
Da qui il vero senso della festa: la fine del ciclo vegetativo coincide con una liberazione, con la realizzazione del progetto. Il raccolto è disponibile e sarà trasformato in vino!
Periodo della vendemmia: quando si raccoglie l’uva
La vendemmia avviene generalmente tra fine agosto e ottobre. Un intervallo lungo e variabile. L’uva è pronta quando è pronta. E ciò dipende da molti fattori. Dal clima, dall’altitudine, dalla particolare esposizione. E poi dal tipo di vitigno. In alcune zone, come l’Umbria, si arriva persino a novembre, come nel caso del Poggio Forno delle Cantine Neri.
Non c’è mai data fissa. La vendemmia può infatti essere interpretata come il risultato di un equilibrio tra maturazione fisiologica e obiettivi enologici. Oggi i produttori valutano il grado zuccherino, cioè la concentrazione di zuccheri nell’uva, che determinerà la gradazione alcolica. Tengono poi conto dell’acidità totale, del pH e della maturazione fenolica, che riguarda tannini e antociani.
Infine, bisogna preoccuparsi anche del corretto sviluppo degli aromi varietali, che si esprimono in modo diverso a seconda della temperatura e dell’esposizione.
Fattori climatici e varietà di vitigno
Il clima è una delle variabili che influisce di più sulla maturazione. Ogni anno bisogna valutare le temperature che hanno contraddistinto le stagioni, bisogna stare attenti alle piogge e alle escursioni termiche.
Tutti questi eventi determinano infatti il grado zuccherino, l’acidità e gli aromi. I vitigni precoci, come per esempio lo Chardonnay, si raccolgono prima, soprattutto se l'estate è stata molto calda. I vitigni tardivi, come il Grechetto o Sagrantino, hanno bisogno di più tempo per svilupparsi. Ma in questi ultimi anni, con il fenomeno del riscaldamento globale, i vecchi calendari appaiono come riferimenti poco affidabili.
In generale, le annate calde implicano vendemmie anticipate, uve più zuccherine e un’acidità più bassa. Le annate particolarmente fresche o piovose comportano una vendemmia ritardata. E non è sempre un bene… Il rischio principale è quello che l’uva sviluppi delle muffe. Per contro, la vite può anche impreziosirsi con aromi più fini.
Una determinata escursione termica può invece favorisce la sintesi aromatica e la stabilità dell’acidità.
Differenze tra nord, centro e sud Italia
I climi più freschi, con piogge distribuite e forti escursioni termiche danno forma a una maturazione più lenta. Ed è per questo che spesso, in territori dove le stagioni sono meno clementi, si sviluppano vitigni precoci o a maturazione media.
Per contro, in zone più calde, come quelle del Sud Italia, il trend è quello di preferire la maturazione tardiva, come succede con l’Aglianico, il Nero d’Avola e il Primitivo, ovvero uve che beneficiano del clima caldo e soleggiato per sviluppare pienamente zuccheri, tannini e aromi complessi. Ma non è escluso che si proceda in senso opposto. Dipende da ciò che si vuole ottenere…
In generale, possiamo comunque affermare che nel Nord del Paese, la vendemmia tende a essere più precoce. Per ragioni climatiche, ovviamente, ma anche per assecondare tendenze agronomiche particolari.
Tradizionalmente, è tra fine agosto e metà settembre che si comincia a vendemmiare in vigne consacrate al Pinot Nero e allo Chardonnay. Stessa cosa per quanto concerne il Glera, che è l’uvaggio usato per il Prosecco.
Si anticipa la raccolta per evitare le piogge autunnali e pure per preservare l’acidità naturale dell’uva. Laddove il clima è particolarmente fresco, con temperature più basse e forti escursioni termiche tra giorno e notte, la maturazione è rallentata. E ciò favorisce la sintesi di aromi delicati e la conservazione dell’acidità.
Così prendono forma vini più acidi e minerali. Gli spumanti metodo classico, i bianchi aromatici e i rossi leggeri del Nord Italia rispettano dunque il criterio della vendemmia precoce.
Il Centro Italia presenta invece una varietà meno uniforme di microclimi. Ci sono zone caratterizzate da climi più rigidi, come l’entroterra abruzzese, e poi aree costiere più temperate, come le coste laziali e marchigiane. Ecco perché le Regioni centrali alternano colture tardive e precoci.
Tra i vitigni a maturazione media ci sono il Sangiovese, che viene raccolto tra fine settembre e inizio ottobre, e il Chianti. Il Trebbiano Toscano, il Grechetto e il Verdicchio sono invece a maturazione scalata. Il Montepulciano e il Malvasia sono varietà che beneficiano di una maturazione lenta ma non estrema. In generale, il Centro consente una vendemmia selettiva, con raccolta scalata per parcelle.
E poi c’è il Sud, dove la maturazione è più rapida e la vendemmia è precoce. Il clima favorisce vitigni a maturazione tardiva ma accelerata dalla temperatura. La vendemmia, nel Meridione, comincia quindi molto presto in alcune zone costiere e pianeggianti. Già a fine agosto, per esempio, viene fuori la Falanghina. Ma il ciclo può durare fino a ottobre nelle aree collinari o per le vendemmie tardive.
Come si fa la vendemmia
La qualità del vino dipende in larga parte da come e quando si raccoglie l’uva. Quindi la vendemmia è anche una scelta… Il produttore deve capire cosa vuole ottenere, che tipo di lavoro assecondare e con quale scopo. Esistono due principali modi per raccogliere i frutti della vite. Lo si può fare a mano o affidandosi alle macchine.
Tutto ciò avviene sempre dopo l’opportuno monitoraggio della maturazione, tramite campionamenti e degustazioni per valutare l’equilibrio aromatico. Quando poi arriva il momento giusto per l’azione, si procede filare per filare, con il taglio del grappolo e il trasporto in cassette.
Le uve raccolte vengono portate in cantina. E qui comincia la diraspatura. Dopodiché si passa alla pigiatura e alla fermentazione.
Vendemmia manuale e vendemmia meccanica
Gli operai chiamati a partecipare alla vendemmia devono dunque tagliare i grappoli senza rovinare le piante. Ci sono vigne che si prestano specificatamente a un lavoro manuale, altre che sono invece progettate per essere curate tramite le macchine.
La vendemmia manuale si pratica con forbici o coltelli. Si tratta di selezionare solo i grappoli sani e maturi e di intervenire sulla vite con precisione e delicatezza. La tecnica è quella nota ai contadini da millenni…
Le macchine vendemmiatrici sono state introdotte negli anni ’60 in Francia e sono arrivate in Italia più o meno negli anni ’80 dopo qualche anno di legittima diffidenza. Il loro funzionamento si basa su un sistema di scuotimento che stacca gli acini dai grappoli. Tutta l’uva da usare per la vinificazione viene quindi direttamente convogliata in vasche di raccolta tramite dei nastri trasportatori.
Un tempo queste macchine erano molto basiche e quindi poco precise. Oggi sono dotate di sistemi di selezione ottica, sensori di maturazione, GPS e possono anche essere integrate con l’intelligenza artificiale, che ne adatta i movimenti e la velocità, per un’automazione di grande qualità.
Vantaggi e svantaggi delle diverse tecniche
La vendemmia a mano è ancora la tecnica ideale per vigneti collinari e terrazzati. O per lavorare con vitigni più delicati. Selezionando grappolo per grappolo, alla fine si ottiene una qualità elevata, senza stressare le viti e senza rischiare l’ossidazione degli acini. Ma tutto ciò richiede manodopera, tempo e fatica. Quindi costa parecchio.
La vendemmia meccanica è più rapida, ed è particolarmente adatta alle vigne di grande estensione. Ovviamente, è meno precisa e comporta il rischio di danneggiare l’uva. Chi vuole sbrigarsi e risparmiare, però, non può fare a meno di sposare le innovazioni tecnologiche.
La vendemmia tardiva: caratteristiche e particolarità
Si parla di vendemmia tardiva quando la raccolta avviene oltre il periodo canonico, spesso a fine ottobre o addirittura a novembre. Quando le uve restano sulla pianta, si disidratano. In questo modo concentrano zuccheri e aromi.
Ma questa tecnica non è adatta a ogni tipo di vitigno. E non richiede solo pazienza: con la vendemmia tardiva entra sempre in gioco un po’ di rischio. Bisogna mettere in conto il clima instabile… Piogge o grandinate improvvise possono rovinare l’uva. E poi bisogna anche evitare l’attacco fungino indesiderato. Se la muffa non è “nobile”.
Sbagliando i tempi, l’uva può rovinarsi. E se il fine è quello di ottenere vini più intensi, più dolci o più complessi, bisogna calcolare bene i tempi, in base all’annata e a tutte le altre variabili.
Cos’è la vendemmia tardiva
Per ottenere un determinato effetto, l’uva va lasciata sulla pianta dalle tre alle sei settimane in più rispetto ai tempi stabiliti. E durante questo tempo ci si deve assicurare che l’uva perda acqua per disidratazione naturale, concentrando di conseguenza zuccheri e aromi.
In Umbria, le vendemmie tardive sviluppano passiti e muffe nobili, come Poggio Forno delle Cantine Neri. In Trentino e in Veneto, tale tecnica è usata con il Recioto. In Sicilia, la vendemmia tardiva dà vita a vini assai riconoscibili come il Moscato di Noto e la Malvasia delle Lipari.
Anche la Francia punta spesso sulla vendemmia tardiva, come nel caso di alcuni vitigni tipici dell’Alsazia che poi si sviluppano nei Vendanges Tardives.
Vini da vendemmia tardiva e profili aromatici
I vini da vendemmia tardiva sono spesso passiti. Dunque dolci e vellutati, con note di miele, frutta secca, spezie. La maturazione prolungata può dar forma anche a vini aromatici, dai profumi intensi e dal corpo pieno. E con acidità bilanciata.
In generale, la vendemmia tardiva è assecondata per produrre vini dolci naturali, senza aggiunta di zuccheri. E poi per ottenere profili aromatici più complessi. Le note di miele, albicocca secca, zafferano e spezie che rendono così particolari alcune bottiglie nascono il più delle volte da tale scelta produttiva.
In altri casi si tratta di valorizzare vitigni autoctoni in condizioni climatiche favorevoli. Come, per esempio, le nebbie mattutine e gli autunni asciutti.
Vendemmia tardiva in Umbria: eccellenze e tradizione
L’Umbria, con il suo clima temperato e le nebbie autunnali, è per esempio una terra ideale per la vendemmia tardiva. Il Poggio Forno delle Cantine Neri, raccolto a novembre, è un esempio emblematico. Questo vino di grande eleganza si ottiene con vitigni Grechetto e Sauvignon e con la muffa nobile.
Ne parlavamo poco più su… l’uva lasciata a maturare può essere attaccata dal Botrytis cinerea, un fungo che, in condizioni climatiche particolari, favorisce la concentrazione degli zuccheri, degli aromi e della complessità gustativa.
Il fungo perfora la buccia dell’acino, favorendo la disidratazione. A differenza della muffa grigia, che marcisce l’uva, la muffa nobile non distrugge il frutto, ma lo trasforma. Da qui il profumo elegante di questo vino e il suo gusto armonico.
Il ruolo del clima umbro
Le nebbie di Bardano, le escursioni termiche collinari e le notti umide sono elementi che contribuiscono a creare le condizioni perfette per l’appassimento naturale e lo sviluppo della muffa nobile. Ma è un equilibrio fragile, che richiede esperienza e sensibilità da parte del viticoltore.
Le colline della Regione, specie quelle dell’orvietano, delle zone di Montefalco e del Trasimeno, sperimentano di decise escursioni termiche tra giorno e notte, soprattutto in settembre e ottobre.
Lo sbalzo termico è importante per preservare l’acidità naturale delle uve e per favorire lo sviluppo degli aromi nei vitigni a bacca rossa e bianca. Inoltre, il particolare clima rallenta la sovramaturazione, permettendo così vendemmie più tardive senza perdita di qualità.
Vini passiti e specialità del territorio
Oltre al Poggio Forno, l’Umbria offre altri vini a vendemmia tardiva di ottima qualità. Come il Sagrantino passito di Montefalco o il Trebbiano spoletino passito. E c’è anche il Vinsanto dei Colli del Trasimeno.
Sono tutti vini da meditazione, da fine pasto. Bottiglie speciali, che raccontano tanto di una terra e di una cultura. Nella Regione si producono diversi vini passiti, tutte dalle tradizioni antiche e articolati in tante varietà locali. Sovente si riscoprono anche sapori che sembravano estinti, come quello della Vernaccia di Cannara.