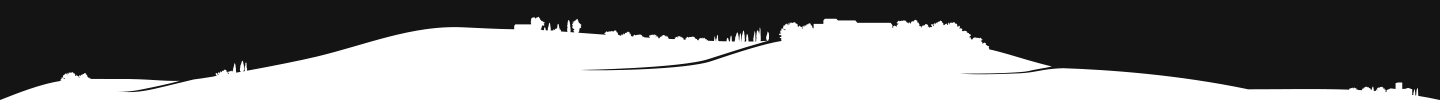Dietro ogni sorso di vino c’è un processo affascinante e sofisticato, gestito da organismi unicellulari chiamati lieviti.
Come fa il mosto a trasformarsi in vino? C’è un particolare processo biochimico da analizzare, e per parlarne con cognizione bisogna cominciare dall’individuare e conoscere i principali artefici del piccolo miracolo che ha cambiato la storia umana: i lieviti, appunto.
I lieviti sono microrganismi unicellulari, prevalentemente appartenenti al genere Saccharomyces. Cellule eucariote classificate come specie del regno dei funghi. Secondo i biologi, il primo lievito dovrebbe aver avuto origine centinaia di milioni di anni fa. E attualmente conosciamo più di millecinquecento tipologie di lieviti. Il sospetto, però, è che la scienza abbia saputo individuare e poi studiare solo l’1% di tutti quelli realmente esistenti.
Il lievito più studiato è il Saccharomyces cerevisiae. Il motivo è semplice: è il microrganismo sfruttato da millenni nella panificazione e nella produzione di bevande alcoliche. Ma non solo… I ricercatori lo hanno coltivato per comprendere meglio la biologia della cellula eucariotica e, indirettamente, quella umana.
Tipologie di lieviti e loro funzioni
Ogni tipo di lievito si fa veicolo di sviluppo di caratteristiche specifiche. In enologia, la scelta del ceppo può rivelarsi dunque fondamentale. Dall’uso di un determinato lievito parte infatti il processo che porterà alla costruzione del profilo sensoriale della bottiglia in produzione.
Siamo soliti distinguere fra lieviti indigeni (o autoctoni), lieviti selezionati (o commerciali) e altri generi di lieviti usati in co-fermentazione. I primi sono quei microrganismi presenti naturalmente nelle bucce dell’uva, nel terreno dove si sviluppano le viti e nell’ambiente della cantina. Non si aggiungono a posteriori e riescono ad attivare fermentazioni spontanee.
I lieviti commerciali vengono invece dai laboratori enologici. Si addizionano manualmente al mosto per ottenere una fermentazione più controllata. Gli ultimi lieviti sono quei microrganismi che arricchiscono il bouquet aromatico del vino.
Lieviti indigeni (autoctoni): la voce del territorio
Tutti i lieviti fondamentali per la vinificazione sono già presenti nell’uva. O meglio, nella buccia e sulle foglie della vite. Altri si muovono nell’aria, nell’ambiente della cantina. Sono i lieviti indigeni, anche noti come autoctoni, patrimonio espressivo della biodiversità locale, nota distintiva che rimanda al luogo dove l’uva è coltivata e poi vendemmiata.
Grazie alla fermentazione spontanea, quella che l’uomo ha usato per migliaia di anni senza nemmeno comprenderne fino in fondo il meccanismo, i lieviti indigeni premiano il vino con una qualità distintiva fondamentale e irripetibile. Un marchio che dona aromi complessi e vari. E che garantisce autenticità e unicità.
Lieviti selezionati (commerciali): precisione e controllo
Oggi le cantine ricorrono sempre più spesso a lieviti selezionati, ovverosia a ceppi commerciali già testati per garantire un determinato effetto. Con tali organismi è possibile affrontare ogni fase dell’evoluzione del prodotto senza dover sottostare a incontrollabili sorprese.
Grazie ai lieviti commerciali è possibile debellare molti dei possibili difetti organolettici del prodotto. Ed è anche facile offrire al vinificatore la capacità di dar forma a sapori più ripetibili e di conseguenza riconoscibili.
Si tratta dunque di strumenti indispensabili per la standardizzazione propria di chi insegue uno stile enologico preciso, affidabile. Il pericolo, in questi casi, è che il processo possa attenuare le sfumature del territorio.
Co-fermentazione e lieviti non-saccharomyces: nuove frontiere
I lieviti non-Saccharomyces e gli altri generi di lieviti sfruttati in co-fermentazione, come il Torulaspora, il Candida stellata, il Pichia e il Metschnikowia pulcherrima, non sono più responsabili principali dell’alcol, ma si rivelano utili soprattutto per amplificare i profumi e modulare l’acidità e il corpo del vino.
Sanno dare freschezza ai vini bianchi e finezza ai rossi e permettono anche di gestire la gradazione alcolica (riducendola, in risposta al cambiamento climatico). C'è però un grosso problema: vanno usati con criterio quasi scientifico e non è mai facile l’uso combinato con i Saccharomyces.
Più la biologia impara a conoscere questi lieviti e più i produttori di vino capiscono come sfruttarne le particolari capacità enzimatiche. Il loro dosaggio apre a infinite nuove possibilità: nuovi profumi, nuove emozioni…
Il processo di fermentazione alcolica
I preziosi lieviti non fanno altro che metabolizzare gli zuccheri presenti nel mosto. Un’azione, a posteriori, interpretabile come un processo di fermentazione. Non succede solo con il vino… I lieviti compiono il loro particolare lavoro in altri fenomeni tanto comuni quanto fondamentali, come la lievitazione del pane e la fermentazione della birra.
Il saccarosio (lo zucchero da tavola) è una molecola doppia, formata da glucosio e fruttosio. Affinché i lieviti possano utilizzarlo, c’è bisogno che questa molecola venga prima di tutto smontata. Di ciò si preoccupa un enzima chiamato invertasi, capace di rompere il legame originale e liberare C12H22O11 + H2O.
Il risultato? Due zuccheri semplici, pronti per essere trasformati. Ed è qui che i lieviti cominciano a darsi da fare con la fermentazione alcolica. Un processo che parte dalla reazione nota come glicolisi, che avviene nel cuore della cellula. Il lievito riesce quindi a prendere lo zucchero semplice e a trasformarlo in alcol ed energia (con uno scarto inevitabile: l’anidride carbonica).
Tutto ciò avviene senza ossigeno in una sorta di meccanismo emergenziale cui i chimici danno il nome di fermentazione anaerobica. La durata di questo processo dipende dalle condizioni ambientali. Di solito passa una settimana. Ma si può arrivare anche a due.
Fattori che influenzano l'attività dei lieviti
Trasformando gli zuccheri del mosto in alcol etilico e anidride carbonica, i lieviti contribuiscono anche alla creazione del profilo aromatico del vino. Per far sì che il compito dei microrganismi sia portato a termine nel migliore dei modi è essenziale che il processo avvenga in un ambiente consono.
Ci vuole insomma la temperatura giusta ed è anche importante che sia garantito al prodotto vendemmiato, diraspato, pigiato e ormai in fase di fermentazione un pH equilibrato. Occorrono poi dei nutrimenti atti ad alimentare e a sostenere i lieviti (vitamine, azoto assimilabile, sali minerali…).
Prima abbiamo parlato della fermentazione come un processo anaerobico, ma una piccola quantità iniziale di ossigeno può aiutare la moltiplicazione degli operai della trasformazione dell’uva in vino.
Temperatura, pH, nutrienti: l'ambiente ideale
Il bravo vinificatore deve saper regolare bene il termostato della fermentazione. La temperatura ideale è quella tra i 18 e i 25°C per i vini rossi o tra i 16°C e i 20°C per i bianchi. Con un clima troppo freddo la fermentazione può essere rallentata o addirittura bloccata. Quando la temperatura è troppo alta, i lieviti si stressano, lavorano più del dovuto e danno origine a elementi sgraditi o sgradevoli (aromi non previsti, una complessità ingestibile).
Il range ottimale per il pH è tra 3.2 e 3.6. Un pH troppo basso, cioè sotto il valore 3.0, potrebbe impedire la corretta crescita delle cellule eucariote. Se il ph fosse troppo alto, la fermentazione andrebbe fuori controllo e si esporrebbe il vino alla contaminazione batterica. Un pH equilibratamente acido aiuta invece la selezione dei ceppi attivi.
Come accennato, poi, i lieviti hanno bisogno del giusto nutrimento. Soprattutto di azoto assimilabile (l’APA), fondamentale per la moltiplicazione cellulare, lo sviluppo di aromi secondari e la regolazione dei composti solforati. Servono poi le vitamine, come la B12. Dei sali minerali e gli steroli.
Di norma, tali nutrimenti si aggiungono tramite degli attivanti organici o sotto forma di fosfato di ammonio. Bisogna infine controllare anche la concentrazione di zucchero. Quando è troppo alta, la fermentazione potrebbe bloccarsi. E se è troppo bassa, il vino potrebbe assomigliare a un analcolico: senza carattere.
Impatto dei lieviti sulle caratteristiche del vino
Con la fermentazione, i lieviti generano esteri, aldeidi, alcoli superiori e acidi organici. In pratica, dei composti chimici che danno sapore e profumo al vino. Gli esteri hanno a che fare con lo sviluppo degli aromi fruttati. Gli alcolici superiori danno forma alle note floreali e speziate. Gli alcoli, invece, favoriscono l’entrata in scena dei sentori di pane tostato, nocciola…
Ogni ceppo di lievito ha un corredo enzimatico unico. Di conseguenza, cambiando il lievito cambiano anche gli aromi che si svilupperanno, sia in quantità che in qualità. In piccole quantità, i composti chimici creati dai lieviti arricchiscono quindi il bouquet di un vino. Ma in eccesso, possono dar origine a difetti.
I lieviti producono anche glicerolo, una sostanza che aumenta la sensazione di rotondità al palato e dà dolcezza. Alcuni lieviti non-Saccharomyces, come il Candida stellata, sono sfruttati proprio per la potenza di produzione di glicerolo. Poi ci sono dei lieviti che lavorano meglio sull’acidità e la freschezza, quindi più indicati per i bianchi o i rossi più morbidi.
Una fermentazione ben gestita con lieviti selezionati riduce anche la necessità di uso di solfiti. Ecco perché i lieviti, che prima abbiamo con poca generosità associato a degli operai, possono essere descritti tranquillamente come degli ingegneri, o meglio, degli scultori. Artisti capaci di dar forma a un carattere definitivo, modellando con sapienza l’espressività del vino.
Anche le Cantine Neri sfruttano cellule eucariote selezionate per la fermentazione alcolica di vini bianchi e rossi e poi per la seconda fermentazione dei loro spumanti, in particolare nel metodo classico e nel metodo ancestrale. Questi lieviti vengono aggiunti al vino base insieme allo zucchero per avviare la rifermentazione, che avviene direttamente in bottiglia nel caso del metodo classico.
Nel caso del loro spumante metodo ancestrale a base di Grechetto, il processo sfrutta lieviti indigeni e temperature controllate per interrompere e poi riprendere la fermentazione, intrappolando la CO2 e creando un profilo aromatico più rustico, autentico.
Aromi e profumi: il contributo al bouquet
Durante la fermentazione, i funghi unicellulari che si riproducono per gemmazione o fissione danno forma anche ai composti aromatici secondari, quegli imprescindibili elementi che poi arricchiscono il profilo olfattivo del vino.
I lieviti possono altresì liberare i terpeni, come il linalolo e il geraniolo, naturalmente presenti nelle uve, rendendoli percepibili nel vino. Alcuni lieviti sono poi capaci di trasformare precursori tiolici in aromi particolarmente intensi, come quello di pompelmo, di frutto della passione o di bosso.
Più in generale, esteri e alcoli superiori contribuiscono a dar forma a delle note fruttate, floreali e tropicali, tipiche di alcuni vini bianchi. Un esempio è quello del Bianco dei Neri Umbria IGP, un vino particolarmente profumato e intenso, ottenuto da un blend di Chardonnay e Sauvignon in percentuali variabili (a seconda dell’annata), due vitigni noti per i loro aromi vivaci.
Alcuni ceppi di lieviti sviluppano aromi di banana, mela, agrumi o spezie. Nei vini spumanti, ma non solo, dopo la fermentazione, i lieviti degradando (in un processo detto autolisi) rilasciano delle mannoproteine e altri composti che migliorano la complessità aromatica e la struttura della bevanda.
Struttura e corpo: l'influenza sulla sensazione in bocca
Le mannoproteine sono particolarmente importanti. I lieviti che le rilasciano riescono infatti a migliorare la sensazione di rotondità e morbidezza in bocca del vino. In più, molti lieviti interagiscono con i tannini, modulando la sensazione di astringenza.
Possiamo tranquillamente affermare che i lieviti sono in grado di modellare la struttura del vino, definendone il corpo e la sensazione tattile, ovvero ciò che il palato percepisce quando lo si assaggia.
Più in generale, le cellule eucariote determinano quanto alcol viene prodotto, influenzando il corpo della bevanda. Più alcol darà inevitabilmente una sensazione più calda e piena. Un vino meno alcolico risulterà più snello e fresco. In ultima istanza, i nostri invisibili scultori unicellulari rendono il vino più resistente all’ossidazione, prolungandone la freschezza.
Stabilità e longevità: il ruolo nella conservazione
Gli enologi parlando di un buon andamento fermentativo nel momento in cui il processo garantisce la giusta stabilità microbica. Con il rilascio di mannoproteine e di polisaccaridi, i microrganismi indigeni o selezionati svolgono un ruolo primario nella stabilità colloidale del vino.
Le molecole rilasciate dai lieviti sanno per esempio proteggere e preservare il colore del vino, impedendo la precipitazione degli antociani. Sanno anche stabilizzare le proteine, evitando che il prodotto sia inquinato da torbidità e depositi.
I lieviti sono anche responsabili (seppure in minima parte) del rilascio di sostanze antiossidanti: un’altra azione che contribuisce a migliorare l’evoluzione del prodotto nel tempo. Quindi, con i lieviti, il vino sarà più resistente all’ossidazione, in modo che la sua freschezza sia prolungata e che i prodotti più importanti possano esprimere qualità connesse alla longevità, mirando (potenzialmente) all’eternità!