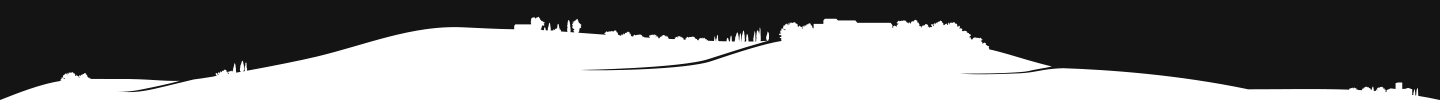L’analisi visiva è molto più di un rituale preparatorio all'assaggio del vino. Con gli occhi si instaura la prima, fondamentale corrispondenza tra chi beve e il contenuto del calice.
L'osservazione va intesa come l'approccio più naturale e insieme suggestivo alla bottiglia stappata e già versata: un'esperienza che assomiglia a un corteggiamento, fatto di sguardi, intuizioni e promesse di felicità.
Con lo sguardo, in un certo senso, si può entrare in sintonia con il vino. Senza questo primo, importante contatto, l’esperienza di degustazione non sarebbe completa o pienamente appagante. Il gioco percettivo ha ovviamente delle regole chiare e una grammatica più o meno complicata da rispettare…
Ma non bisogna spaventarsi né arrendersi a un atteggiamento di deferenza. Tutti possono partecipare al rito dell’analisi visiva: basta saper approcciare il vino con gli occhi; un’azione consentita a principianti ed esperti, bevitori distratti e appassionati!
Decifrare il linguaggio del colore del vino
Prima di lasciare che il naso cominci a cogliere certi aromi e che il palato possa sperimentare il gusto e le sfumature del vino, l'interpretazione deve passare per l’occhio.
L’esame visivo è l'incipit della degustazione, il momento in cui il calice comincia a svelare il suo contenuto attraverso tanti indizi interessanti. Colori, toni, densità e qualità si lasciano intendere e studiare attraverso la pura apparenza.
L'essere umano si affida moltissimo alla vista nel giudizio iniziale sia dei cibi che delle bevande. È un'azione istintiva: Il colore, la lucentezza, la forma e persino la disposizione nel piatto o nel bicchiere muovono delle aspettative. Ci sono colori che appaiono più invitanti e altri meno coinvolgenti. Il cervello associa infatti certe caratteristiche visive a qualità specifiche. Come la freschezza, la dolcezza o la maturazione…
Se un vino apparisse opaco e spento, l'assaggiatore potrebbe aspettarsi ossidazione o mancanza di freschezza prima ancora di provarlo. Ma la cultura ci ha insegnato che non è sempre così. E l'uomo non è solo istinto: la cultura è una seconda natura che influenza i giudizi.
Intensità cromatica
Il colore di un vino esprime diversi contenuti. Parla della sua origine, può raccontare del vitigno da cui è nato, dell'età di una determinata bottiglia, della sua conservazione e, in certi casi, persino del metodo di vinificazione.
Un vino giovane, per esempio, tende a esprimere una colorazione più brillante e vivace. Un vino più maturo vira sovente verso tonalità più evolute.
Per orientarsi fra le possibilità espressive del colore bisogna farsi esegeti, adoperando un vocabolario consono e imparando a utilizzare termini specifici, utili a descrivere le sfumature visive che il vino rivela nel calice. Non solo rosso, bianco e rosé… Ogni colore ha le sue tonalità. Ogni tonalità ha la sua particolare intensità.
Tonalità e riflessi
L’intensità riguarda la profondità e la saturazione del colore. Nei rossi, si passa dal rubino chiaro al porpora profondo. Invece, nei bianchi, si va dall’oro pallido al giallo più carico, come nel caso del Poggio Forno, il muffa nobile prodotto dalle Cantine Neri.
Un vino dalla colorazione tenue potrebbe evocare un vitigno delicato. Oppure un gusto fresco o una breve macerazione. Per contro, una colorazione intensa potrebbe indicare una struttura importante. larsciar presagire una lunga persistenza o raccontare di un affinamento in legno.
L'intensità è una misura che ci dice quanto il colore del vino possa essere carico, concentrato. La domanda giusta da porsi sul colore è: quanto “riempie” il bicchiere?
Oltre al colore principale, bisogna guardare anche ai riflessi presenti ai margini. I toni violacei nei vini rossi giovani, le sfumature granato nei più invecchiati… Note che possono parlarci dell'invecchiamento. Nel vino bianco, si possono notare dei riflessi verdolini che indicano freschezza. Le tonalità ambrate evocano invece maturità ed evoluzione.
I rossi possono virare sul rubino. È quel rosso vivido tipico dei vini giovani. Il porpora con riflessi violacei è invece presente nei rossi robusti. Poi c'è il granato che si riscontra in certe sfumature bruno-aranciate, indicativo di evoluzione. I riflessi granato sono sfumature cromatiche che si osservano ai bordi di un vino rosso, specialmente se in fase di evoluzione. Questa tonalità richiama il rosso-bruno del melograno maturo e spesso si nota nei vini invecchiati. Il passaggio da toni violacei a granato è un indizio visivo del tempo e dell'affinamento che il vino ha subito.
Il color mattone è un tono aranciato saturo che indica un invecchiamento spinto. Il violaceo dai riflessi bluastri è in genere tipico dei vini rossi molto giovani.
Per i bianchi si parla di paglierino quando il colore è giallo chiaro con riflessi verdolini. Una sfumatura tipica dei vini freschi. Il dorato è un giallo più caldo, proprio dei bianchi maturi o affinati in legno.
L’ambrato è un giallo tendente al bruno, indice di ossidazione o buon invecchiamento. I rosati possono andare dal rosé tenue simile alla buccia di cipolla, caratteristico dei rosati provenzali. Poi c'è il rosa cerasuolo con sfumature ciliegia, più intense e vivaci. Il ramato può derivante da vinificazioni particolari.
La trama cromatica è invece la descrizione complessiva del colore, dove si analizzano insieme l’intensità, nella tonalità e nei riflessi.
Limpidezza e consistenza
La limpidezza dipende dall'assenza di particelle o di torbidità. Ed è un segnale di una corretta filtrazione o di giusta maturazione. Un vino può essere dunque vino brillante, se rivela una limpidezza cristallina, o trasparente, limpido (quando la luce passa completamente attraverso la sua sostanza) e velato. Ci sono anche vini “impenetrabili”. Per esempio, quei rossi molto concentrate, la cui colorazione scura è talmente intensa da rendere impossibile distinguere un’immagine presente dietro il bicchiere.
La consistenza si osserva roteando delicatamente il vino nel calice. Bisogna guardare alle cosiddette lacrime. Quegli archetti che rivelano la componente alcolica e glicerica. Più sono lente e persistenti, maggiore sarà la struttura e l’estratto del vino. La consistenza è quindi legata al contenuto di sostanze diverse dall’acqua e responsabili a del profilo organolettico del prodotto. Sono sostanze che bisogna “muovere”. Ecco perché per valutare la consistenza l’analisi non può essere statica.
La brillantezza indica la capacità del vino di riflettere la luce. Un vino brillante appare vivo e quasi scintillante. Di solito è un buon segno, specie per i vini giovani e buona acidità. Un aspetto più opaco o spento può suggerire stanchezza oppure ossidazione.
Una leggera opacità, che può comparire in alcuni vini naturali o non filtrati, non va intesa come un difetto. In certi casi, è un effetto di una vinificazione artigianale.
La tecnica dell'esame visivo del vino passo dopo passo
L’analisi visiva è una pratica non solo sensoriale ma anche una questione tecnica. I sommelier dedicano tanta attenzione a questa analisi non solo per far scena…
Ci sono alcuni passaggi fondamentali. È un rituale fatto di gesti precisi e ben calibrati. Passaggi utili a focalizzarsi sul colore, poi sulla limpidezza, quindi sull’effervescenza e, infine, sulla consistenza.
Si parte sempre osservando il calice dall’alto. Poi si impugna il bicchiere e lo si inclina leggermente. Poi si riporta il calice in verticale e si fa roteare il suo contenuto.
L'Inclinazione del calice
Inclinare il calice su uno sfondo bianco, come per esempio una tovaglia o un foglio, permette a chi analizza di osservare sia il centro che i bordi del vino. Ciò aiuta a percepire meglio la tonalità generale e i riflessi, che spesso sono più evidenti lungo l’anello esterno del vino.
L’inclinazione è utile anche per valutare la limpidezza. Con un’inclinazione di 45° si può analizzare il colore.
L'osservazione in controluce
Si porta spesso il bicchiere contro una fonte luminosa. Lo si per valutare la limpidezza e la presenza di eventuali sedimenti. La brillantezza, come abbiamo anticipato, è sinonimo di cura nella produzione…
Ovviamente, il bicchiere deve essere perfettamente pulito e riempito per metà. Ci vuole anche un ambiente ben illuminato. Solo con l’analisi in controluce è possibile scorgere anche la minima presenza di particelle.
L'analisi della goccia (o lacrima)
Dopo una leggera rotazione, il vino forma degli archetti sulle pareti del calice. La velocità e la consistenza con cui queste lacrime scendono rivelano il corpo e la viscosità del vino, offrendo diverse informazioni sulle sue caratteristiche.
Gli archetti sono appunto quelle sottili striature che il vino lascia come una traccia. Dei solchi che si formano grazie alla presenza di alcol e sostanze gliceriche. La velocità e la densità con cui cadono danno quindi un’indicazione della struttura del vino: archetti lenti e fitti suggeriscono un vino più ricco di alcol, estratti e corpo.
La glicerina è un composto naturale prodotto durante la fermentazione alcolica. Ha consistenza oleosa e contribuisce alla morbidezza e alla rotondità percepite al palato. Ed è responsabile, assieme all’alcol, della formazione degli archetti nel bicchiere. Un vino ricco di glicerina apparirà infatti più viscoso e, di conseguenza, avrà un impatto più setoso e caldo in bocca.
L'importanza dell'esame visivo del vino
L’esame visivo del vino non è una pratica riservata agli esperti. Sembra un rituale rigidissimo e pieno di segreti, ma, alla fine, non è una cosa tanto complicata. Può anche essere inteso come un procedimento intuitivo. Poi, ovviamente, studiando, è possibile scoprire il fascino dell'analisi più tecnica, che è sempre assai interessante e appassionante.
Tutti quanti, ordinando un calice di vino, sono istintivamente portati a osservarlo. E osservando bene si può essere investiti da una ricchissima gamma di informazioni. Il colore, la trasparenza, i riflessi e persino il modo in cui il vino scivola sulle pareti del calice sono indizi immediati e accessibili a tutti…
È un po’ come apprezzare un’opera d’arte. Mica serve una laurea in storia dell'arte per godere della bellezza di un quadro! E qui abbiamo a che fare con colori e sfumature. Dettagli che tutti possono cogliere e valutare.
Un primo indizio sulla tipologia e le caratteristiche del vino
Dal colore si possono intuire tanti dettagli fondamentali. Dato che il colore del vino è determinato da alcuni fattori chiave, dall’osservazione della colorazione e della limpidezza sarà sempre possibile capire qualcosa sulla varietà dell'uva (se a bacca rossa o bacca bianca), sulla macerazione, l’invecchiamento e altro.
Va detto che molti grandi vini bianchi vengono ottenuti da uve a bacca rossa… Un caso noto è quello dello Champagne, che può essere prodotto partendo non solo dallo Chardonnay ma anche dal Pinot Noir e il Pinot Meunier.
La macerazione è il tempo di contatto tra il mosto e le bucce dell'uva durante la fermentazione. Una fase fondamentale per l'estrazione dei colori: maggiore è il tempo di macerazione, più intenso sarà il colore del vino. La maturazione, cioè l'invecchiamento, è un altro fattore che incide sul colore. Lo stesso vale per il processo di vinificazione: le diverse tecniche possono influenzare il colore. Un rosso con fermentazione in acciaio apparirà meno saturo di un rosso maturato in botte.
Con gli occhi si coglie anche l’evoluzione cromatica, cioè il cambiamento del colore nel tempo proprio del l’invecchiamento.
Preparare il palato
L’occhio prepara il cervello all’esperienza sensoriale. Un vino dorato fa presagire dolcezza e morbidezza. Un rosso brillante, invece, suggerisce freschezza. Le possibilità sono infinite… l’esame visivo genera aspettative e allena la consapevolezza del degustatore.
I sommelier dicono spesso che il colore è molto di più di un’impressione visiva accessoria: è un vero e proprio biglietto da visita, un’introduzione che dà il via e senso all’esperienza che si sta per affrontare.
Un elemento chiave per una valutazione completa
Una degustazione tecnica non può mai prescindere da un’attenta valutazione visiva. Con gli occhi si ottiene un primo profilo sensoriale, che andrà poi confermato, smentito o affinato dagli esami olfattivo e gustativo.
In ambito professionale, osservare il calice è fondamentale per garantire coerenza e affidabilità nella descrizione del vino.