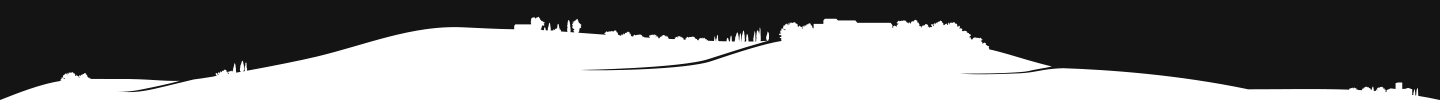Quando le foglie della vite cominciano a prendere il colore del rame e la vendemmia è appena terminata, compare il vino novello, l’essenza più dolce dell’autunno.
Un vino nuovo, frutto di una tecnica particolare. Non basta la giovinezza del prodotto a dar vita al vino novello. Serve seguire un metodo tradizionale, quello della macerazione carbonica, possibile grazie alla fermentazione dei grappoli interi, in assenza di ossigeno.
La tecnica, sorta in Francia con il Beaujolais Nouveau, è stata poi adottata con successo anche in Italia, dove la tradizione dei novelli ha espresso da subito un forte carattere e un’orgogliosa tendenza alla specificità.
Cos’è il vino novello e perché è speciale
Si parla di novello in presenza di un rosso ottenuto da uve appena raccolte, fermentate in un tino ermetico saturo di anidride carbonica. L’obiettivo è quello di favorire una fermentazione intracellulare, senza una pigiatura iniziale.
Bisogna che l’uva fermenti dall’interno, sviluppando aromi particolari e una struttura leggera. In pratica, è essenziale tenere a bada i tannini. In Francia parlano di vino en primeur, cioè ancora in fase di vinificazione.
Da noi in Italia, il novello è sinonimo di vino venduto nello stesso anno della vendemmia da cui esso proviene. Ma non si deve commettere l’errore di fraintendere l’essenza di un prodotto che nasce e si sviluppa assecondando regole specifiche di vinificazione.
La differenza tra vino novello e vino giovane
Il vino giovane, come dice il nome, è un prodotto che non ha fatto in tempo a invecchiare. È stato messo in bottiglia secondo i metodi tradizionali: pigiatura, fermentazione alcolica, travasi vari… dopodiché, entro pochi mesi, è finito a tavola. È fresco e, senza dubbio, può essere piacevole. Ma non rileva nulla di particolare dal punto di vista tecnico.
Il vino novello, invece, è tutta un’altra storia. Come accennato, è il risultato di una tecnica particolare, perfezionata in Francia, nel Beaujolais, negli anni ’30, quindi adottata in tutta l’area mediterranea e poi nel mondo. Una tecnica che cambia l’essenza stessa del prodotto.
Nel novello, l’uva non viene pigiata subito e mai interamente. I grappoli interi vengono messi in una vasca satura di anidride carbonica. E lì succede qualcosa di speciale: gli acini fermentano intrinsecamente, da dentro. È una fermentazione intracellulare, che dura pochi giorni (cinque, secondo la consuetudine transalpina).
Ed è così che si dà vita a un vino leggero e profumato, con pochissimi tannini. La tradizione ha voluto che questo vino si facesse espressione di un momento preciso dell’anno: l’autunno.
C’è una data precisa da tenere a mente: il 6 novembre. Si tratta del giorno in cui può essere messo in commercio. E quindi consumato… Perché l’altra caratteristica fondamentale del novello è la stagionalità. Non si conserva e non si colleziona in cantina. Si deve bere quanto prima.
Origini e tradizione del vino novello in Italia
Volendo giocare al divertente gioco dell’archeologia enologica, potremmo dire che il vino novello esiste nel nostro Paese da più di duemila anni. I contadini dell’antica Roma producevano il vinum preliganeum, ricavato da uve immature, da bere durante la vendemmia. Una bevanda dal sapore acido, ma particolarmente apprezzata dal popolo. E rinomata anche fra i poeti…
Plinio il Vecchio elogiava il vino dei Voconzi, una popolazione gallica, la cui fermentazione veniva bloccata immergendo i dolia in acqua fredda fino all'inverno, quando arrivava il momento di stappare le bottiglie.
l vini novelli veri e propri sono arrivati in Italia negli anni ’70 come reinterpretazione del Beaujolais Nouveau francese. Da subito, però, queste forme di vinificazione si sono ricollegate a più antiche tradizioni. Quelle connesse alla celebrazione dell’autunno. Così, nelle campagne italiane, il novello è diventato espressione di convivialità e di orgoglio contadino.
Ancora oggi è un simbolo dalla cosiddetta estate di San Martino, la festa contadina che segna la fine della vendemmia e l’inizio del vino nuovo. Il proverbio, lo conoscete? A San Martino ogni mosto diventa vino. Martino è il santo della condivisione. Secondo la leggenda, mosso a pietà, tagliò il proprio mantello per donarne un pezzo a un povero. Il vino novello, che si beve in compagnia, incarna proprio tale spirito di generosità e comunica uno speciale senso di calore. Il calore della giornata di sole consacrata al santo. E quello umano, cagionato dalla vicinanza e dalla solidarietà.
Come si fa il vino novello
Uno o due giorni prima della raccolta, l’enologo prende una piccola parte dell’uva, di norma circa il 10% del volume della vasca, e la pigia per far partire subito la fermentazione. Tale processo produce anidride carbonica, che colma la vasca e protegge il resto dell’uva dall’ossigeno, in modo da non permettere fenomeni ossidativi.
Qui comincia la macerazione carbonica, la fermentazione dentro l’acino. Le uve intere vengono messe nella vasca piena senza ossigeno. All’interno degli acini, comincia così un processo chimico che sviluppa aromi fruttati e colori vivaci. Man mano che gli acini si rompono per il loro stesso peso e per effetto della fermentazione, il succo comincia a uscire e riempie la vasca.
A questo punto si passa al processo della svinatura anticipata. Ovvero ci si preoccupa di separare il liquido prima che tutto sia finito. Bisogna aspettare però qualche giorno. Facendo attenzione a togliere il succo dalle bucce prima che la fermentazione sia completata.
Lo si fa per permette di estrarre più velocemente i pigmenti, cioè gli antociani, e gli aromi. Inoltre, è più facile controllare la fine della fermentazione nel liquido che nelle bucce. L’anidride carbonica prodotta nella prima vasca può poi essere usata per saturare le vasche successive. In modo da evitare sprechi e contaminazioni.
Il succo che esce naturalmente dall’uva, senza pressa, viene detto mosto fiore. È la parte pregiata, quella più colorata, aromatica e alcolica.
La tecnica della macerazione carbonica
Tale tecnica si dimostra perfetta per ottenere vini giovani e aromatici. Ma non è cosa da tutti. Bisogna essere esperti e attrezzati. Occorrono vasche ermetiche e serve poter contare su una saturazione precisa di CO2. Bisogna anche porre massima attenzione alla temperatura.
Il minimo errore nella gestione del processo può compromettere la fermentazione e favorire lo sviluppo di difetti. Infine, si tratta di una tecnica che si applica bene a vitigni specifici. Vitigni poco strutturati o aromaticamente modesti, per esempio, possono guadagnare in piacevolezza grazie alla macerazione carbonica. Sfruttare uve più pregiate può invece essere un errore.
In generale, con questo tipo di tecnica si punta alla creazione di un vino vivace. L’espressione pura della freschezza di una particolare annata. E, va da sé, che sia da intendere come inadatta per dar forma a vini più complessi.
La normativa italiana è molto chiara. Affinché un vino ottenuto possa definirsi novello, il processo di vinificazione carbonica deve interessare il 40% delle uve. Poi, la restante parte può essere trattata con tecniche di vinificazione classiche.
C’è dunque ampia discrezionalità concessa ai produttori. Ecco perché la percentuale di vino ottenuto da macerazione carbonica è diversa da vino a vino. Si parte dal 40 e si arriva al 100%.
Tempi e peculiarità del processo produttivo
Le uve destinate al novello vengono di norma raccolte tra fine settembre e inizio ottobre. La tradizione vuole che si agisca prima della piena maturazione, per preservarne la freschezza e l’opportuna acidità.
La macerazione carbonica dura dai tre ai dieci giorni. In Italia, i tempi medi sono sempre superiori ai cinque giorni. Poi arriva il momento di separare il succo dalle bucce prima che la fermentazione sia completata.
Dopodiché avviene anche la fermentazione alcolica finale. Una fase che può durare da due a cinque giorni. Il mosto fiore continua a fermentare in vasche separate, sotto stretto controllo tecnico. E tutti i produttori sanno che la fermentazione è più facile da gestire nel liquido che nelle vinacce.
Periodo del vino novello: quando si beve e normativa
Produzione, commercializzazione e consumo del vino novello seguono un calendario abbastanza rigido. C’è una normativa che, oltre a stabilire le tecniche con cui va vinificato e poi messo in vendita, chiarisce pure i tempi attraverso cui questo primo vino dell’annata possa farsi apprezzare dal pubblico.
Questi limiti hanno senso perché il vino novello è un prodotto stagionale, pensato per celebrare la fine della vendemmia e che si snaturerebbe prolungano il proprio ciclo. Inoltre, la tradizione ne ha collegato il consumo in concomitanza di un importante rito collettivo, legato alla cultura contadina.
Il disciplinare (dato al D.M. del 6 ottobre 1989, modificato in seguito dal D.M. 13 agosto 2012) serve a tutelare la qualità e la trasparenza, evitando pure che dei vini giovani vengano spacciati per novelli.
L’uscita ufficiale sul mercato
Vi è dunque un periodo ufficiale per l’immissione in commercio. Si parte dalle 00:01 del 30 ottobre dell'annata di produzione delle uve utilizzate fino al 31 dicembre. Fino a una decina di anni fa, il limite massimo era il 6 novembre. E per molti produttori questa data resta moralmente vincolante.
Prima del 30 ottobre, oggi, il vino novello non può essere consegnato al consumatore finale. E ogni anno è così. Una scelta che ha senso dal punto di vista tecnico anche se ha perso il suo forte valore simbolico. Prima della fine di ottobre è infatti impossibile che sia garantito il completamento minimo della fermentazione.
La data contempla un tempo minimo di vinificazione, considerando che la vendemmia avviene, di norma, tra settembre e ottobre. Il 6 novembre aveva maggiore impatto simbolico perché anticipava poi di qualche giorno la festività di San Martino, che cade l’11 del mese, l’importante evento della tradizionale festa che celebra la fine della vendemmia e l’arrivo del vino nuovo.
La breve vita del vino novello
Il vino è una bevanda che di solito fa pensare all’invecchiamento. Il novello fa eccezione. Non aspira a essere conservato come prodotto prezioso né si sogna di migliorare col passare dei giorni e dei mesi.
Nasce già pronto e pretende di essere bevuto subito. Anche perché, nel giro di poche settimane, può perdere senso, ovvero svuotarsi delle sue caratteristiche principali. Vale a dire la sua freschezza e la fragranza.
L’incapacità di perdurare del novello non è un difetto: è la sua identità. La scelta culturale e tecnica alla base della sua produzione mira proprio a dar vita a un vino intenso da godere nell’immediato. La sua durata massima è di due mesi. Oltre ha perso la sua freschezza e dunque il suo senso.
Caratteristiche del vino novello
Un vino novello si distingue in base al profumo, al colore e al gusto. E a una gradazione alcolica contenuta entro un certo range. In quasi tutte le sue espressioni si tratta di un prodotto vivace e fresco. Ecco perché va bevuto giovane: non bisogna dargli modo di spegnersi o perdere freschezza.
Di solito lo si ordina prima della produzione, in modo da averlo a disposizione subito. Oppure lo si prende durante le fiere e le feste che accompagnano le celebrazioni di San Martino.
Le sue caratteristiche lo rendono il vino più adatto da mettere in tavola a inizio novembre, nei giorni piovosi autunnali, quando comincia a tornare la voglia di mangiare castagne, di servire salumi e formaggi freschi e di preparare piatti rustici.
Colore, profumi e gusto
Il colore distintivo del novello è un rosso rubino brillante, in molti casi con dei riflessi violacei. Tale intensità cromatica non deve tendere alla profondità. Altrimenti significa che qualcosa non è andato per il verso giusto durante l’estrazione rapida degli antociani, ovvero con la macerazione carbonica.
Il prodotto deve essere pure limpido. In qualche caso può presentare una leggera effervescenza naturale. Come succede per esempio con il Lambrusco.
Gli aromi sono fondamentali per la buona riuscita del novello. Devono venir fuori note di frutta rossa fresca. Fragola, lampone, more… In alcuni novelli emergono sentori di violetta e banana.
Il bouquet non è mai complesso. Deve risultare immediato, schietto. Quanto al gusto, da un novello ci si aspetta morbidezza, assenza quasi totale di tannini, acidità moderata e struttura leggera. Deve insomma essere un vino facile da bere. Che scende giù che è una bellezza, come si dice in dimensione conviviale.
Grado alcolico e freschezza
L’altra caratteristica chiave è la gradazione alcolica contenuta. Solitamente un novello si pone tra l’11% e il 12%. Raramente si va oltre. Se fosse più alcolico perderebbe di leggerezza e di freschezza. Sotto l’11% non può scendere. Il disciplinare impone questa gradazione alcolica come il valore minimo in volume.
C’è anche un limite massimo di zuccheri riduttori residui: per essere chiamato novello, il vino non deve superare i 10 grammi per litro.
La freschezza aromatica è, senza dubbio, una delle qualità più ricercate nel novello. Ma è una caratteristica legata alla sua espressività contestuale. Se non si consuma subito, entro massimo due mesi, il vino perde vivacità.
Abbinamenti del vino novello in tavola
Questo compagno ideale per i piatti tipici della tavola autunnale va preso per il verso giusto: come prodotto conviviale da abbinare senza troppa pretenziosità.
Il vino novello vuole dunque farsi apprezzare insieme a pietanze semplici, di stagione, preferibilmente legate al territorio e alla tradizione. E dato che l’autunno è una stagione che fa pensare a sapori terrosi, rustici e a piatti caldi, è automatico tirare in ballo caldarroste, zuppe di legumi, polente, pasticci…
Con piatti autunnali e castagne
L’accoppiamento classico è con le castagne. Bollite o arrostite. La dolcezza delle castagne si sposa benissimo con la morbidezza e i profumi fruttati del novello. Ma l’abbinamento funziona anche con le zuppe di legumi. Di lenticchie, ceci, fagioli, eccetera… il vino alleggerisce la struttura del piatto e ne esalta la componente rustica.
Nel Nord Italia, con il novello si mangia la polenta. Con funghi o salsiccia. Questo perché è un vino adatto a bilanciarsi con la grassezza.
In altre parti d’Italia, con il novello a tavola arrivano le torte salate con zucca, porri o cipolle.
Abbinamenti con formaggi e salumi
Il Teroldego, uno dei novelli più rinomati prodotti in Italia, è un vino che si abbina perfettamente ai salumi trentini, come lo speck, ma anche a formaggi stagionati. Anche gli altri novelli, prodotti lungo tutta la penisola, riescono a esaltare il classico tagliere salumi e formaggi.
D’autunno, prima dell’inverno, per tradizione si assaggiano i formaggi e i salumi freschi di stagionatura. E il novello, con la sua acidità moderata e il suo basso contenuto di tannini, è un accompagnamento indicato per vari formaggi freschi o a pasta molle.
La cremosità delle caciotte fresche, della robiola e dello stracchino ha bisogno di un vino non aggressivo. Si può ottenere la giusta armonia anche con formaggi leggermente stagionati.
I salumi giovani e più delicati, ma anche quelli un po’ più grassi e saporiti, come il salame, il lardo e la pancetta, si faranno apprezzare meglio in compagnia di un vino leggero e fresco come il novello.
Vino novello e dolci tipici
Non parliamo di un vino da dessert, ma in Italia, il novello è tradizionalmente abbinato a diversi dolci rustici. Uno su tutti: il castagnaccio. Nel Meridione, il novello è anche il vino da bere quando si porta a tavola il migliaccio o quando si consumano dolci artigianali alle nocciole.
Anche i biscotti, sempre alle nocciole o alle mandorle, da gustare alla fine del pasto o a merenda, possono star bene insieme a un novello. In Sicilia, si preparano i biscotti di San Martino e si cerca sempre l’abbinamento con un novello Nero d’Avola o Alcamo. Per dolci più semplici come le torte di mele serve poi una bevanda poco alcolica e leggera.
In Umbria, con le ciambelle al vino si assaggia sempre qualche sorso di novello. A base di Merlot o un Assisi DOC, per esempio. Lo stesso con la rocciata, un dolce autunnale a base di mele, noci e uvetta.