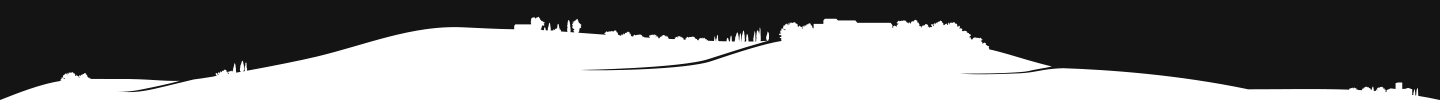Si può godere di un calice di vino anche senza attardarsi in uno scrupoloso esame gustativo? Certo che si può… Quando si beve, non è affatto necessario chiedersi quanto il suo tannino sia vellutato, se e come la persistenza sia rilevante e quali siano le sensazioni retronasali da enumerare.
In realtà, il palato esamina e si interroga sulle qualità particolari di un vino anche senza impegnarsi in un esame tecnico. La bocca invierà comunque dei segnali al cervello. E chi assaggia saprà dunque distinguere fra vini graditi e vini meno adatti al proprio gusto, cominciando presto a riconoscerne e apprezzarne le caratteristiche più sofisticate.
Confrontarsi con un esame gustativo significa imparare a giudicare con il palato, assaggiare e al contempo interrogarsi sulle qualità e la sostanza di ciò che si sta gustando, imparando a interpretare aspetti riguardanti la sua struttura, la freschezza e la persistenza.
Cos’è l’esame gustativo e perché è fondamentale nella degustazione del vino
L’esame gustativo è il capitolo terzo dell’entusiasmante avventura della degustazione. Superata l’analisi visiva e l’esame olfattivo, arriva il momento clou: quello dell’assaggio vero e proprio. Solo il palato saprà infatti capire qual è la vera personalità di un vino, riconoscere la sua storia e il suo sapore.
Gli esperti non si fermano ovviamente al giudizio secco e semplicistico del “mi piace” o “non mi piace”. Scompongono il contenuto da valutare in diversi aspetti o problemi, da studiare singolarmente, con metodo, per capire meglio con cosa hanno a che fare e in che modo ogni dettaglio possa funzionare o non funzionare nell’economia del prodotto.
Per apprezzare un vino non basta sapere che è fatto con determinate uve vendemmiate in quell’anno. Bisogna capire come si comporta in bocca: se sa esprimere al meglio le proprie qualità e se riesce a rivelare tutto il proprio gusto…
I principali elementi da valutare nell’esame gustativo del vino
L’esame gustativo si basa dunque su alcuni parametri codificati. Passaggi analitici che ci aiutano a non banalizzare l’esperienza della degustazione, trasformando l’assaggio completo e consapevole in una semplice bevuta.
Il vero giudizio del vino può avvenire solo seguendo un iter sensato e strutturato, assecondando pratiche che hanno una storia secolare, consigli dettati dalla storia dell’esperienza sensoriale e poi da una standardizzazione operata da parte di esperti.
Sommelier professionisti, uniti in associazioni come l’AIS, la FISAR, la ONAV e la WSET hanno infatti creato metodi di degustazione strutturati, definendo le linee guida per un’analisi completa, che tenga conto di aspetti culturali, scientifici e produttivi.
Ed è importante avere un metodo d’indagine codificato. Tra assaggiatori bisogna parlare la stessa lingua. Quando il sommelier presenta un vino equilibrato, chi assaggia deve sapere cosa aspettarsi. Altrimenti sarebbe anche impossibile valutare oggettivamente la qualità di un vino…
Attacco: la prima sensazione al palato
Il primo impatto con un vino è fondamentale. Come spesso accade nelle cose della vita, l’impressione immediata ha un peso specifico enorme nella valutazione generale. Ma l’analisi strutturata deve appunto impedire che il primo approccio si tramuti in un frettoloso giudizio. Si procede per gradi. Quindi, appena il vino entra in contatto con lingua e palato è necessario concentrarsi solo su alcuni aspetti.
Il vino può essere morbido e avvolgente, come per esempio un Amarone della Valpolicella, o più fresco e tagliente. Ci sono vini più timidi, che si esprimono cioè lentamente e non colpiscono al primo impatto, e altri più aggressivi.
L’attacco ci dice subito quali sono le caratteristiche dominanti del vino. E ci rivela anche con cosa abbiamo a che fare… Alcuni vini si presentano con eleganza, salutando con discrezione le nostre papille gustative. Altri sembrano più energici e trascinanti: ci avvolgono subito in un abbraccio caloroso.
Ma quel primo istante non rivela ogni aspetto del prodotto: ci sono qualità che possono esprimersi solo dopo, attraverso l’analisi di altre caratteristiche. Con l’assaggio iniziale il nostro cervello può registrare solamente le note dominanti e più evidenti. Per esempio, la potenza di un rosso più strutturato, l’acidità di un bianco mediterraneo o la dolcezza di un passito.
Fermarsi a questa prima impressione sarebbe però come giudicare un’intera opera solo dall'ouverture o un romanzo dal primo paragrafo. L’attacco è importantissimo e rivelatore, ma non corrisponde all’essenza ultima e completa dell’oggetto da valutare.
Evoluzione e corpo: la struttura del vino in bocca
Con l’evoluzione si valuta la progressione del gusto e la consistenza. Un Brunello di Montalcino ben fatto rivelerà per esempio un corpo deciso. Un vino leggero scivolerà via lieve.
L’analisi non riguarda il gusto in sé. Bisogna concentrarsi sul come il vino riempie la bocca. Un vino corposo si riconoscerà allora perché denso e avvolgente. In certi casi consistente quasi come un olio. Un vino leggero apparirà immediatamente più fluido e sottile. Scivolerà via più velocemente.
Con il primo assaggio è possibile anche valutare la struttura. Ovvero il particolare equilibrio tra alcol, acidità, tannini e zuccheri. Ci sono vini dove l’alcol è più percepibile: sono quei sorsi che scaldano subito lingua e palato. I vini più leggeri risulteranno invece meno alcolici e di conseguenza meno invasivi e caldi.
Sarà possibile poi cominciare a valutare l’estratto secco, cioè tutto ciò che resta nel vino se togliamo l’acqua e l’alcol. Si tratta della parte solida: gli zuccheri non fermentabili, gli acidi, i vari sali minerali, i tannini (nei rossi), i polifenoli e le sostanze aromatiche… E ci sono vini ricchi di sostanze e altri poveri di componenti strutturali.
Bisogna sapersi fare le domande giuste per valutare la struttura e il corpo di un vino. Con i tannini, per esempio, bisogna capire se sono ruvidi o setosi e in che modo la loro presenza si accorda alla consistenza del vino.
Riguardo all’acidità è invece bene chiedersi se è troppo pungente o ben integrata. Con l’alcol, è importante saper notare se brucia o se scalda più piacevolmente.
Persistenza gustativa: il finale e il retrogusto
Il vino non è fatto per essere assaggiato e poi sputato: va bevuto. Quindi deve finire in gola e poi nello stomaco. Ma quando se ne va lascia comunque delle tracce in bocca. La persistenza è il tempo in cui il gusto rimane dopo la deglutizione. Un Barbaresco di annata può per esempio restare in bocca molto più di quanto sia possibile immaginare.
Una persistenza corta determina quindi un fugace ricordo sensoriale in bocca di ciò che si è bevuto. La persistenza media è quella in genere più ricercata: piacevole ma non invasiva.
La permanenza lunga è propria dei vini importanti. E in certi casi è così intensa da donare a chi assaggia una soddisfazione sensoriale di quasi mezzo minuto. Per orientarsi in questa fase dell’analisi è infatti possibile cronometrare il tempo in cui il sapore e l’aroma del vino restano percepibili e distinguibili dopo averlo deglutito.
Si parla di consistenza breve, se i sapori vanno via dopo un paio di secondi. La persistenza media può durare fino a sette secondi. Quella lunga supera i dieci secondi. Gli esperti decantano come memorabile e toccante la persistenza di quei vini che si protrae per tredici, quattordici, venti secondi…
Equilibrio e armonia tra le componenti
Nell’analisi gustativa bisogna saper riunire gli elementi scomposti in un esame sintetico. Dopo essersi concentrati sulle caratteristiche più evidenti, sul peso, sulla consistenza, sulla presenza d’alcol e sulla persistenza, è bene capire come questi dettagli si armonizzano fra loro.
L’alcol in eccesso potrebbe per esempio stonare rispetto a un’acidità elevata. In effetti, l’armonia tra dolcezza, acidità, tannini e alcol è ciò che distingue un vino di qualità da un vino dozzinale.
In questo caso, però, è più difficile essere clinici e oggettivi. L’armonia è un concetto più sottile e dunque soggettivo. Si va oltre l’equilibrio misurabile e tecnico. Bisogna quindi interrogarsi sulla sensazione complessiva di piacevolezza, coerenza ed eleganza. Un vino potrebbe per esempio essere tecnicamente equilibrato ma non armonico.
Le sensazioni tattili e retronasali: oltre il gusto
Il vino non è solo espressione di sapori. Ci sono sensazioni tattili (calore, astringenza, morbidezza) e retronasali (aromi che risalgono dal palato al naso) da saper cogliere e apprezzare. È come se il vino avesse una seconda voce, un contrappunto, più sottile ma altrettanto importante.
Le sensazioni tattili sono quelle che si percepiscono con la lingua, con il palato e pure le gengive. E non si tratta di gusto, ma di una sensazione legata al riconoscimento della forma e della consistenza del vino.
Le sensazioni retronasali sono quelle percezioni aromatiche che salgono dal retro della bocca al naso, dopo la deglutizione. Non si tratta di annusare il vino contenuto nel calice (ciò dovrebbe essere già stato fatto durante l’analisi olfattiva, precedente a quella gustativa). Si sta invece percependo ciò che dopo l’assaggio arriva al naso.
Tannini, morbidezza e freschezza: l’equilibrio tattile
Per riconoscere e valutare le sensazioni tattili e retronasali bisogna deglutire lentamente e chiudere gli occhi. Dopodiché è necessario respirare dal naso per partecipare del racconto retronasale e poi concentrare l’attenzione sulla bocca, per sentire la particolare trama del vino, intuirne la temperatura, l’intensità e la morbidezza.
Ci sono vini che carezzano o altri che graffiano. I tannini possono donare una sensazione di astringenza o di immediata secchezza. Ci si accorge della loro presenza quando ci si sente tirare le gengive…
I tannini giovani sono in genere più aggressivi e dunque graffianti. Quelli maturi appaiono più avvolgenti ed eleganti. E, se ben integrati, danno struttura senza disturbare. La morbidezza è invece ciò che rende il vino appagante: è la rotondità coniugata alla dolcezza tattile e al calore. Un effetto che dipende dall’alcol, dagli zuccheri residui e anche dalla presenza di glicerina.
Un vino con alcol ben dosato può per esempio scaldare senza bruciare. Un vino troppo zuccherato può essere un po’ stucchevole. La giusta glicerina dà corpo e scorrevolezza. E di solito la morbidezza può ben bilanciare l’asprezza: un Ca’ Viti Orvieto Classico Superiore DOP prodotto dalle Cantine Neri ha per esempio una base asprigna derivante dalla presenza di uve come Grechetto e Procanico, che donano freschezza e acidità, ma sa esprimere anche rotondità grazie alla presenza di uve Chardonnay e Sauvignon.
Ed ecco quindi un perfetto esempio di equilibrio tattile, di un vino che risulta vivace ma armonico, con un attacco fresco e un’evoluzione morbida e avvolgente.
La freschezza è il respiro del vino e dipende dall’acidità, ovvero dalla presenza di acido tartarico e malico. I bianchi dalla bassa acidità risultano spesso piatti, quelli con un’alta acidità possono apparire addirittura taglienti.
Aromi retronasali e la loro importanza
Gli aromi possono essere distinti per via ortonasale o retronasale. Nel primo caso, sono gli aromi che si avvertono prima di bere, annusando. Gli aromi retronasali si sentono mentre si deglutisce. O meglio: quando si respira dopo aver bevuto.
Per riconoscere gli aromi retronasali, quindi, non bisogna più concentrarsi nel vino contenuto nel bicchiere ma fermarsi su ciò si è mosso in bocca. Dopo la deglutizione bisogna saper cogliere le note fruttate, speziate o i sentori terrosi.
Gli aromi risalgono naturalmente dalla bocca al naso attraverso la faringe. E assumeranno forme diverse e nuove intensità rispetto agli aromi percepiti al naso. Profumi come quello di vaniglia, di tostatura, di frutta secca e di spezie, di norma, si esprimono solo per via retronasale. Gli esperti riescono a cogliere aromi che raccontano dell’evoluzione del vino, che raccontano l’intero processo di vinificazione, solo dopo la deglutizione.
Come allenare il palato per un esame gustativo più accurato
Sarebbe bene impegnarsi in un esame gustativo ogni volta che si beve un vino. Dopotutto, non c’è nulla di così complicato: basta concentrarsi sulle proprie sensazioni.
Per imparare può essere utile confrontare vini diversi. Si potrebbe provare bevendo un rosso più strutturato e poi un rosso più giovane. Dopo qualche prova, il palato comincerà a riconoscere meglio aromi e caratteristiche.
Serve ovviamente usare i bicchieri giusti e servire i vini a temperatura adeguata. Per poter imparare senza commettere errori, sarebbe poi interessante confrontarsi con una guida, partecipando per esempio a delle degustazioni organizzate o a dei corsi specifici. Anche Cantine Neri offre simili esperienze.