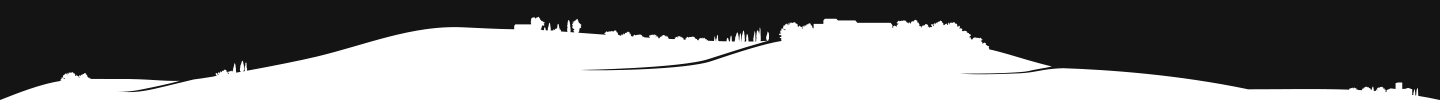Il vino non si beve soltanto... si respira! Con i suoi profumi sa introdurci ai suoi misteri. E sa stregarci con suggestive promesse di piacere.
Le qualità olfattive del vino possono essere colte per via nasale diretta, mediante l’inspirazione compiuta con le narici, prima dell’assaggio. Da subito, il vino può dunque esprimere contenuti importanti, raccontando della sua origine, dell’uva da cui è nato, della terra dove essa è maturata, e del tempo che ha determinato la sua maturazione.
Ma c’è anche un passaggio ulteriore, che avviene durante la degustazione: l’esperienza che segue la via retronasale. Quando gli odori, dalla cavità orale, si muovono verso le fosse nasali (la rinofaringe).
Fateci caso: è l’istinto a suggerirci di avvicinare il naso al calice, o viceversa. Prima dell’assaggio, c’è bisogno di cogliere riferimenti e suggestioni utili a orientarsi, come in un viaggio.
E con i profumi è appunto possibile risalire alla magia delle vigne baciate dal sole, alla poesia un po’ malinconica delle cantine arrese al silenzio, dove le botti si affidano alla cura del tempo. L’esame olfattivo è un’arte naturale e insieme sofisticata: un’indagine nel passato e nell’intimità del prodotto che si sta per assaggiare.
Le fasi dell'esame olfattivo
L'esame olfattivo, nel rito della degustazione, si articola in varie principali tese a saggiare l’intensità, la complessità e la qualità del prodotto. Attraverso questi progressivi approfondimenti sarà possibile valutare il profilo aromatico del vino, cogliere il bouquet e intuire la presenza di sostanze benefiche o nocive.
La profumazione del vino va quindi colta e valutata per gradi, affrontando un percorso che introduce il degustatore a informazioni sempre più importanti e specifiche sulla natura e sulla piacevolezza della bottiglia stappata.
Prima fase: l'intensità e la persistenza
A occhi chiusi, chi degusta avvicina il calice al naso per cogliere alcuni segnali. L’intensità è il primo riferimento da analizzare. Un vino di carattere sprigionerà subito i suoi aromi dominanti. Un vino più delicato, li nasconderà.
Abbiamo dunque a che fare con una descrizione della forza con cui gli aromi giungono alla percezione umana. In tal senso, un vino può essere giudicato come carente, poco intenso, bastevolmente intenso, intenso o molto intenso. La carenza d’intensità è propria dei vini neutri, dai profumi molto deboli. Se gli aromi diventano leggeri e poco percettibili, si entra nel dominio del “poco intenso”.
Quando si cominciano a intuire delle sfumature, più o meno vaghe, si è sulla buona strada: l’intensità ideale è lì vicina. Quando la vivacità olfattiva è manifesta, i profumi giungeranno al naso più definiti, ben pronunciati. E sarà anche possibile individuare alcune sfumature più nette. Se la gamma di queste sfumature diventa ampia e ben marcata, l’intensità è piena.
La persistenza, invece, è l’indicatore attraverso cui intuire e poi misurare per quanto tempo gli aromi restano nel calice e nella memoria. Se gli aromi svaniscono troppo in fretta, la persistenza sarà definita corta. Il vino è poi poco persistente, se il profumo dura solo pochi secondi. Quando gli aromi durano a lungo, anche diversi minuti, si è in presenza di un vino persistente o, addirittura, molto persistente.
Seconda fase: la qualità e la complessità
Quando si è interessati a vivere l’esperienza di un esame olfattivo del vino, non basta percepire un odore. Ci vogliono esperienza e sensibilità. I sommelier, per esempio, sanno giudicare i profumi e gli aromi in base alle categorie di qualità e complessità.
La prima categoria è quella più complicata da intendere ed esprimere, dato che ha a che fare con un giudizio soggettivo. La complessità si riferisce alla varietà e alla ricchezza degli aromi percepiti. Una bottiglia dal carattere complesso presenterà una vasta gamma di profumi che sanno svilupparsi nel tempo.
Una bottiglia di alta qualità avrà aromi intensi, complessi e insieme piacevoli. Per intenderci: un buon vino può farsi apprezzare esprimendo uno o due profumi chiari e gradevoli. Un grande vino fa qualcosa in più: dona un’esplosione di sfumature. Note floreali, fruttate, speziate, minerali… e, poi, ovviamente, un particolare bouquet. Ovvero la particolare sintesi di aromi e profumi che si sviluppa durante la sua maturazione e con l'invecchiamento.
Terza fase: l'identificazione degli aromi
E poi, a un certo punto, il degustatore deve farsi esegeta. Deve saper cogliere note particolari, interpretarle e tradurle. Per farlo, deve saper distinguere fra gli aromi che raccontano dell’uva e quelli che possono essersi sviluppati durante la fermentazione. E, infine, deve saper cogliere anche quei profumi che danno forma al bouquet, ovvero i più complessi e sofisticati.
Ci sono gli aromi fruttati, quelli floreali, legnosi, speziati, vegetali, minerali… E ci sono anche gli aromi che riguardano il corredo aromatico dei vitigni. A livello informale, spesso il concetto di aroma è usato come un sinonimo di bouquet. Ma, nella degustazione, i due termini hanno un significato ben distinto.
Semplificando, potremmo dire che gli aromi sono gli odori che arrivano direttamente dall’uva, tipici dei vini giovani. Come quei profumi che si sentono subito in certi bianchi, tipo l’aroma di litchi nel Gewürztraminer o di ribes nero nel Cabernet Sauvignon. Il bouquet riguarda gli odori che il vino sviluppa col tempo, grazie alle trasformazioni chimiche che entrano in gioco mentre esso matura. Profumi come quello del miele in un Sauternes, o il sentore di tartufo in un Pinot Nero invecchiato.
Classificazione degli aromi del vino
Gli aromi primari non sono altro che i profumi più naturali del vino: quelli che derivano dall’uva, dal vitigno in cui essa è cresciuta. Secondari sono gli aromi che nascono quando il vino fermenta, cioè quando lo zucchero si trasforma in alcol. Poi ci sono gli aromi terziari, che arrivano dopo anni, durante l’affinamento in bottiglia o in botte.
Un vino giovane come il Sauvignon Blanc, per esempio, può evocare il profumo delle foglie di pomodoro o di alcuni frutti tropicali… si tratta, chiaramente, di aromi primari. Un vino bianco invecchiato in rovere potrebbe invece rivelare un sentore di burro e vaniglia… Ecco, quel sentore di burro, spesso presente nello Chardonnay, è un aroma secondario. Ovvero un profumo aggiuntivo che deriva dal processo di vinificazione.
Cioè dalla fermentazione alcolica o malolattica, dall’affinamento in legno (barrique o botti grandi) e dalla maturazione sui lieviti. Quanto agli aromi terziari, un esempio classico in un rosso italiano famoso è la nota di sottobosco che emerge con l'invecchiamento prolungato. Ovvero con l’evoluzione degli aromi primari e secondari nel tempo, con l’ossidazione lenta e i processi di micro-ossigenazione in botti o bottiglie. In un Barolo invecchiato si percepirà infatti un aroma di sottobosco e di cuoio.
Aromi primari: dalle uve al calice
Il profumo passa dunque dal’uva al calice. E quando ciò avviene, la bottiglia esprime dei forti odori primari. Quei particolari aromi legati direttamente al vitigno. ll Ca' Viti di Cantine Neri, per esempio, presenta aromi primari ben riconoscibili, soprattutto nelle annate più giovani.
E visto che parliamo di un Orvieto Classico Superiore, un blend composto principalmente da Grechetto, Procanico, e poi da una piccola percentuale di Malvasia, Drupeggio e Verdello, il degustatore avvertirà sentori di frutta bianca. Cioè albicocca, pera decana… e poi di fiori freschi (ginestra, zagara) ed erbe aromatiche (salvia). E magari anche qualche nota minerale di pietra lacustre.
Anche con il Moscato è facile intuire subito i profumi di salvia e pesca. Stessa cosa con il già citato Gewürztraminer, con il suo caratteristico profumo di litchi e rosa. In una Falanghina campana si coglieranno note di gelsomino e biancospino, agrumi e mele.
Aromi secondari: il frutto della fermentazione
Durante la vinificazione, i lieviti trasformano gli zuccheri e, così facendo, creano nuovi composti aromatici. Nel vino sono infatti presenti composti volatili e non volatili che contribuiscono alla composizione del suo aroma.
Specie durante la fermentazione e per i primi mesi di vita di un vino, si verificano importanti reazioni chimiche tra questi composti. Ecco perché l'aroma cambierà più rapidamente durante tale delicata fase che in qualsiasi altro momento.
Vengono così fuori i composti aromatici che danno al vino il suo profumo. Ma, il più delle volte, quando il vino è chiuso nella bottiglia, questi composti sono "addormentati", perché legati agli zuccheri. Diventano delle molecole chiamate glicosidi, che, in pratica, non hanno odore.
Ma poi si risvegliano. Lo fanno con la fermentazione (o con l’invecchiamento), quando gli enzimi o gli acidi nel vino rompono questi legami attraverso il processo noto come idrolisi. Ed ecco che si liberano gli aromi secondari.
Quando si avvicina il calice al naso, le molecole odorose salgono come piccole vampe invisibili. Una volta entrate nel naso, stimolano dei particolari recettori, ognuno dei quali sensibile a un tipo di profumo. Così si colgono le note di burro, di yogurt, di birra o di banana… Aromi che non provengono dalle uve, ma dal processo stesso di vinificazione.
Aromi terziari: l'evoluzione del vino in affinamento
Il vino riposa in legno o in bottiglia, e sviluppa altri aromi, più sofisticati. Alcuni vini rivelano un aroma caramellato, di vaniglia, caffè, cioccolato, cuoio… Sono profumi più profondi e maturi. Sfumature molto interessanti e coinvolgenti, che raccontano la crescita del vino e il suo riposo in botti o in bottiglia, in un’adeguata cantina, per potersi esprimere al meglio.
I sommelier, dopo aver annusato brevemente il vino, aver poi agitato il calice per far salire gli aromi dominanti ed essere passati all’esame retronasale, possono individuare aromi legnosi e balsamici (che rivelano se il vino è invecchiato in rovere o in botti tostate); speziati (vaniglia, cannella, liquirizia). E ancora: aromi empireumatici (caffè, caramello, tabacco); animali (cuoio, pelliccia); muschiati; eterei; chimici.
Errori comuni e vizi olfattivi
Come ogni opera d’arte, anche il vino può esprimere delle imperfezioni. Spesso, l’ossidazione provoca dei sentori di mela cotta o marsala troppo marcati. E non è un buon segno.
Anche i già citati aromi terziari chimici possono indicare un difetto. Se poi il vino ha subito una riduzione può esprimere odori non gradevolissimi di cavolo o uova marce. I sentori sulfurei non sono quasi mai una caratteristica equilibrata.
Non è però così raro che un carattere definito e giustificato del vino venga interpretato come un difetto. Dipende dall’inesperienza del degustatore. Oppure da una sua presunzione. E non è facile compiere un esame olfattivo perfetto. Prima di tutto, occorre l’ambiente giusto. E ci vuole anche il calice adatto.
Annusare in un ambiente profumato o impregnato di altri odori forti (come succede spesso nei ristoranti) non è l’ideale. Servirebbe un ambiente neutro, senza odori estranei. I bravi degustatori non analizzano gli aromi dopo aver mangiato o fumato. Lasciano passare almeno una mezz’ora dopo la cena o dopo la sigaretta.
Un altro errore solito è quello di roteare troppo o troppo poco il bicchiere. Come dicevamo più su, per cogliere certi aromi, bisogna annusare il vino prima ancora di rotearlo. In caso contrario si perderebbero tutti i profumi più volatili, quelli primari.
Consigli pratici per migliorare l'esame olfattivo
Per un buon esame olfattivo bisogna usare il bicchiere giusto. Il calice troppo largo disperde gli aromi. Quello troppo stretto li comprime. E quindi? Dipende se si sta bevendo un rosso o un bianco. Ma, per cogliere i profumi, il calice ideale ha la forma a tulipano. Quella più funzionale per convogliare i profumi verso il naso.
Un consiglio utile per imparare a interpretare correttamente il rituale dell’esame olfattivo è dedicare sempre un paio di secondi alla prima “annusata”. Quella da fare prima di roteare il bicchiere. Poi si comincia a roteare. Senza esagerare! Un movimento eccessivo potrebbe disperdere gli aromi e far cadere il vino.
Anche il movimento troppo delicato è sconsigliato: non basterebbe a liberare tutti gli aromi. Quindi bisogna provvedere a un paio di giri non troppo timidi né troppo veementi.